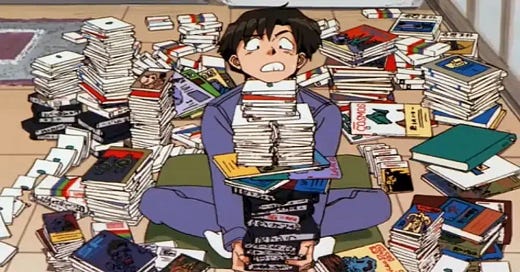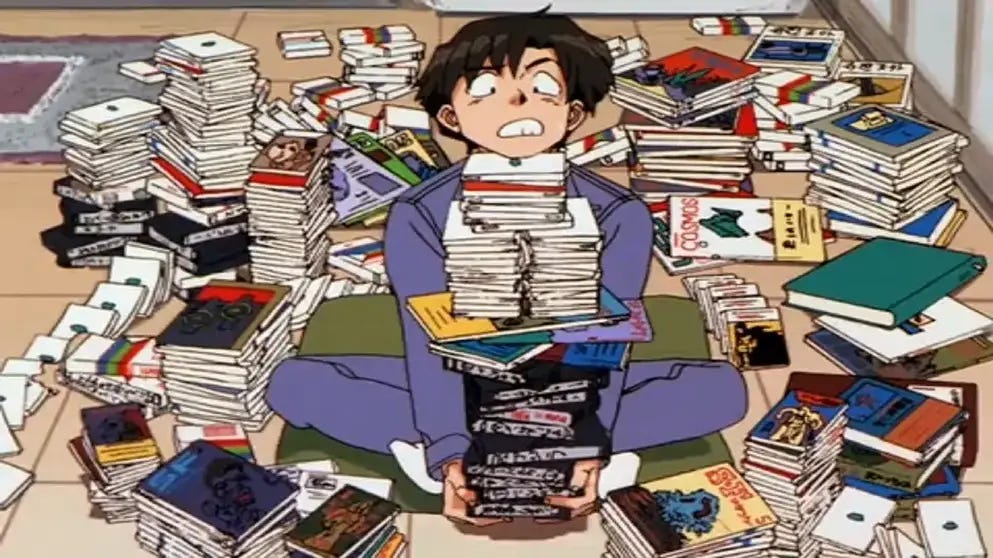Fenomenologia degli otaku
Il testo del filosofo giapponese Hiroki Azuma, riproposto in una nuova edizione da Nero, è ancora utile per comprendere la postmodernità attraverso la lente della subcultura otaku.
Al primo ministro giapponese Shigeru Ishiba piace definirsi “otaku”. Ishiba, infatti, è un grande collezionatore di modellini di diverso genere, tra cui navi e aerei da guerra o, ancora, macchine d’epoca.
Il fatto che oggi il premier del Giappone si appropri e in qualche modo rivendichi il termine “otaku” non è così scontato, perché essere otaku non è sempre stato cool.
C’è stato un momento, alla fine degli anni Ottanta, in cui nel paese esplose un panico diffuso rispetto a questa subcultura e alle persone che ne facevano parte. Nel 1989, la prefettura di Saitama fu scossa da una serie di omicidi in cui quattro bambine di età compresa tra i 4 e i 7 anni vennero molestate, uccise per strangolamento e smembrate.
L’autore dei delitti si chiamava Tsutomu Miyazaki, e quando venne colto in flagrante poco prima che commettesse il quinto omicidio, gli inquirenti scoprirono in casa sua migliaia di VHS di anime, molti dei quali a contenuto horror, splatter e pornografico. Tra il materiale vennero ritrovate anche le registrazioni delle sevizie perpetrate sulle vittime e di Miyazaki intento a masturbarsi sui corpi senza vita delle bambine.
Come scrive il sociologo dei media Marco Pellitteri, fra i maggiori esperti internazionali di fumetto e animazione giapponesi, nell’introduzione al libro “Otaku, la cultura che ci ha trasformato in animali accumuladati”, riproposto in una nuova edizione da Nero,
L’abbinamento fra l’otakuità e le tendenze criminose si rivelò per la stampa un facile sillogismo e il termine, sulla scia di quei delitti, divenne presso ampie fasce dell’opinione pubblica sinonimo di potenziale omicida.
Benvenute e benvenuti alla puntata #39 di Japanica. Gran parte del testo che segue è citato direttamente dal libro di Azuma. Se vi interessa il tema e siete a Roma, giovedì 13 marzo alle ore 19 presenterò il libro insieme a Giorgia Sallusti alla libreria indipendente Giufà.
Animali accumuladati
“Otaku” significa letteralmente “presso la vostra casa” e corrisponde più o meno all’ormai desueto utilizzo del voi in italiano quando ci si rivolge a una persona che non si conosce. Come spiega sempre Pellitteri, il termine fu introdotto consapevolmente dal giornalista Akio Nakamori sulla rivista amatoriale da lui fondata Tōkyō otona club (Club per adulti di Tokyo).
Ci sono diverse ipotesi su come questo termine abbia iniziato a diffondersi nella subcultura di anime e manga: una delle più plausibili è che nei primi anni Ottanta i due noti autori di anime Shōji Kawamori e Haruhiko Mikimoto lo utilizzassero tra loro, con i colleghi all’interno della società di animazione e nelle interviste rilasciate alle riviste specializzate.
Anche l’autrice di fantascienza Motoko Arai, a metà anni Ottanta, scrisse un libro in cui si rivolgeva ai lettori con la formula otaku.
Fatta questa premessa, possiamo dire che oggi ci occuperemo di otaku ma da una prospettiva insolita, che è quella descritta da Hiroki Azuma nel già citato “Otaku, la cultura che ci ha trasformato in animali accumuladati”.
Il testo è stato pubblicato per la prima volta nel 2001 dalla prestigiosa casa editrice Kōdansha, a cui seguirono le pubblicazioni in Corea del Sud nel 2006, in Francia nel 2008 e negli Stati Uniti nel 2009.
La prima traduzione in italiano arriva nel 2010. Oggi, Nero ci ripropone questo testo come strumento per interpretare la post-modernità.
Azuma, classe 1971, è un critico e filosofo militante – una figura a cavallo tra l’accademia e l’attivismo intellettuale. La sua attività letteraria – cito sempre Pellitteri – è da intendersi come un’“azione culturale”, ovvero un intervento sulla cultura inteso a cambiarla in senso polemico, nell’accezione marxiana.
La fine delle grandi narrazioni
“Le polemiche suscitate dal caso Miyazaki hanno reso estremamente difficile, sino alla fine degli anni Novanta, una riflessione oggettiva e diretta sulla cultura otaku – scrive Azuma nel primo capitolo – […] l’obiettivo di questo libro è provare a correggere questo squilibrio per permettere di analizzare la cultura otaku e, nello stesso tempo lo stato attuale della cultura giapponese, senza preconcetti, al fine di creare una situazione di maggiore obiettività”.
Ma perché all’autore interessa tanto analizzare senza pregiudizi la cultura otaku?
Secondo Azuma,
L’essenza della nostra epoca, la postmodernità, si rivela molto chiaramente nella struttura e nel funzionamento della cultura otaku.
Insomma, questa sottocultura nata nel paese ritenuto postmoderno per eccellenza – il Giappone – è lo strumento per interpretare la contemporaneità e i cambiamenti che attraversano la società. Gli otaku sono l’avanguardia antropologica attraverso cui studiare le differenze tra l’uomo moderno e l’uomo postmoderno.
Fino alla metà del XX secolo, ci pensavano le grandi narrazioni a riunire i membri di una comunità: lo Stato, il Partito o Dio sul piano ideologico e la supremazia della produzione su quello economico. Nell’epoca postmoderna, invece, molte di queste grandi narrazioni hanno attraversato disfunzioni tali da indebolire la coesione sociale.
Per Azuma, l’evento più significativo in questo senso è l’attentato al sarin nella metro di Tokyo nel 1995, per mano della setta Aum Shinrikyō (il 20 marzo ricorreranno i trent’anni dalla tragedia).
Il movimento, fondato nel 1987 da Shōkō Asahara e al quale aderivano nell’anno dell’attentato circa 9mila membri in tutto il paese, espletò il ruolo di sostituire la grande narrazione dell’ideologia politica. La setta Aum, che vedeva tra le prime file giovani uomini laureati in materie scientifiche, ha costruito una dottrina fondata su elementi immaginari.
La grande differenza tra l’Armata Rossa Giapponese degli anni Settanta (per approfondire leggi qui) e la setta Aum Shinrikyō degli anni Novanta – scrive Azuma – consiste nel fatto che la prima credeva nel comunismo, una grande narrazione ampiamente riconosciuta e legittimata, invece i membri di Aum avevano fede in una narrazione che ancora oggi trova fortissime resistenze a essere riconosciuta collettivamente.
Simulacri e archivi di dati
In questo sfaldamento delle grandi narrazioni, gli otaku (che vengono distinti in tre generazioni) adottano una fruizione puramente consumistica di piccole narrazioni volgendo la propria attenzione – ossessiva – non tanto alle trame di anime e manga, ma ai dettagli delle ambientazioni e dei personaggi.
Questo tipo di fruizione appare evidente se pensiamo all’anime di grande successo Evangelion. Fin dall’inizio, gli appassionati hanno dimostrato un attaccamento eccessivo, “che si potrebbe qualificare come paranoia”, per elementi estrapolati dall’anime senza penetrare nel suo universo.
Così, mentre il creatore Hideaki Anno pensava alle produzioni successive, lo studio Gainax metteva in vendita giochi da tavolo con i personaggi dell’anime, carte telefoniche con disegni erotici della protagonista femminile, Rei Ayanami, o videogiochi in cui gli utenti dovevano accudire sempre Rei.
Citando Jean Baudrillard e Walter Benjamin, Azuma introduce il concetto di simulacro, che è l’altro grande pilastro a sostegno della tesi del libro.
L’otaku, ovvero il prototipo dell’uomo postmoderno, visualizza il mondo come un immenso archivio di dati, secondo un impianto a-gerarchico e bidimensionale – Azuma lo chiama iperpiatto – dove le piccole narrazioni hanno tutte eguale valore e assumono lo stato di mere finzioni, di simulacri – per l’appunto, nell’accezione di Baudrillard – prive della facoltà di ricondurre a un racconto complessivo.
Di fatto, quindi, non si pone più alcuna distinzione tra l’opera originale e i derivati che i singoli consumatori traggono dall’enorme archivio di dati (simulacri) che hanno contribuito ad accumulare. L’autore – scrive ancora Azuma – non è più un dio. Non viene neppure nominato. In sua vece sono gli elementi d’attrazione moe (carini, attraenti, teneri – in altre parole cute) a essere divenuti idoli.
A questo punto, rimane da capire perché Azuma definisce gli otaku “animali accumuladati”.
Secondo l’interpretazione del filosofo Alexandre Kojève, dopo la Seconda guerra mondiale si è diffuso negli Stati Uniti un tipo di consumatore che Kojève definisce animale. L’essere umano non ha più desideri da nutrire, ma solo bisogni da soddisfare nell’immediato attraverso il consumo merci.
Per Azuma, anche in Giappone si è realizzato questo processo tanto che decide di chiamare il periodo successivo al 1995 “era dell’animalità”: l’uomo postmoderno non riesce a soddisfare il suo anelito a dare un “senso” alla vita con le relazioni sociali, ma piuttosto lo soddisfa in solitudine, tornando a bisogni animaleschi.
Ormai non vi sono più legami tra le piccole narrazioni e le grandi non-narrazioni, e il mondo intero si limita semplicemente a fluttuare senza che sia possibile assegnare un significato nell’esistenza di nessuno.
La decisione della casa editrice Nero di ripubblicare questo testo a distanza di quasi venticinque anni dall’uscita in Giappone e quindici dall’arrivo in Italia conferma come la visione di Azuma sia più che mai attuale, soprattutto se pensiamo all’accumulo digitale di dati che ognuno di noi tende a fare (sui propri dispositivi o all’interno di database smaterializzati come i cloud), o al bombardamento a cui siamo sottoposti utilizzando quotidianamente piattaforme tech dell’intrattenimento.
In conclusione, Azuma tenta di rispondere a una domanda quanto mai cruciale:
Con il decadere della nozione di trascendenza, che ne è del senso di umanità degli esseri umani? La mia risposta provvisoria è questa: riduzione dei significati all’animalità, perdita di senso del concetto di umanità, individuo dissociato in cui coabitano l’animalità al livello dei simulacri e l’umanità al livello degli archivi di dati.
In breve
Questa settimana il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato in visita ufficiale in Giappone. La sua terza e ultima tappa è stata a Hiroshima, al Memoriale e al Museo della Pace. A seguire ha incontrato i rappresentanti della Nihon Hidankyō, l’associazione degli hibakusha premio Nobel per la pace nel 2024 (ne avevo scritto nella puntata #22)
Per rispondere a questa email, proporre una collaborazione o suggerirmi un tema per la newsletter rispondi a questa email o scrivimi a eleonorazocca3@gmail.com. Mi trovi anche su Instagram, Bluesky e TikTok.